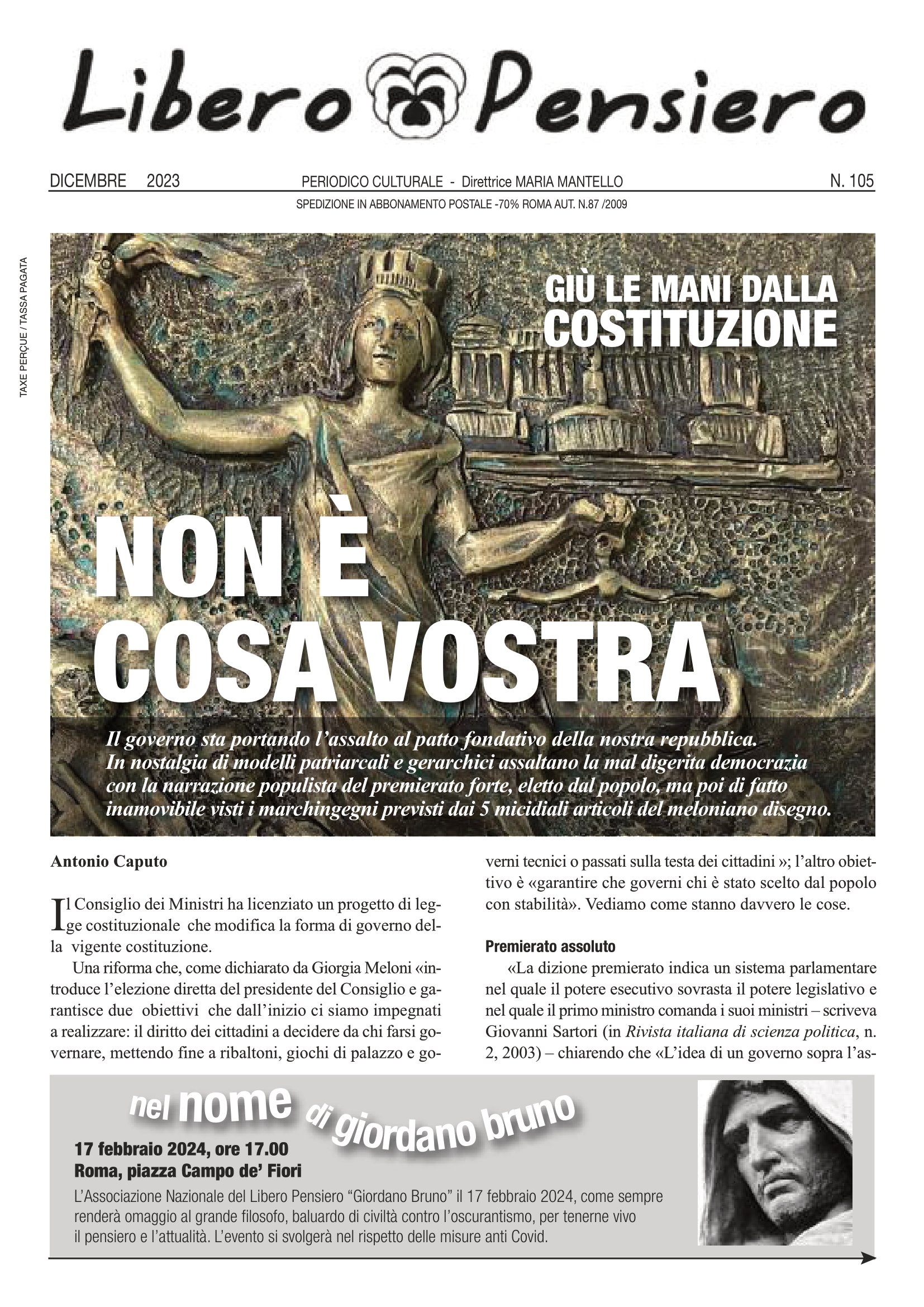TAGLIA 52: VALUTARE UNA
SCUOLA IMPOVERITA
Relazione del prof. Alvaro
Belardinelli al Convegno Educare alla critica: quale valutazione? –
Roma, Liceo “Terenzio Mamiani”, 26 novembre 2013
di Alvaro Belardinelli

Negli ultimi
vent’anni si è parlato sempre più insistentemente della necessità di
valutare i risultati della Scuola italiana. Intendendo, con il
termine “risultati”, le “competenze” raggiunte dagli studenti
durante il percorso scolastico e al suo termine. Esigenza
innegabilmente legittima. Non si può certo negare, infatti,
l’importanza di conoscere il funzionamento della Scuola
dall’interno, osservando e valutando se essa stia ottenendo il suo
scopo: migliorare il livello di istruzione del Paese, combattere la
dispersione scolastica, eliminare le storiche differenze culturali
tra Nord e Sud, tra aree centrali e zone periferiche, tra centri
cittadini e suburbi, tra città e campagna. Il dettato costituzionale
parla chiaro, specialmente all’articolo 3. La Scuola è l’istituzione
che meglio incarna l’esigenza di dare a tutti i cittadini le
medesime opportunità, affinché essi possano esprimere al meglio le
proprie potenzialità, con una ricaduta positiva su tutta la
collettività. Dati a tutti i medesimi strumenti, pareggiate le
differenze sociali che possono impedire di mettere a frutto le
proprie capacità, è giusto premiare il merito e le capacità stesse
(come prescrive l’articolo 34 della Costituzione), in modo che
queste capacità e questo merito tornino utili a tutta la nazione.
Purtroppo, però, negli stessi anni in cui i nostri Governi (di ogni
colore) spingevano l’acceleratore sul processo di valutazione della
Scuola, non s’investiva sulla Scuola nemmeno una lira; e,
dall’ingresso nell’euro, nemmeno un centesimo. Nel 2008, poi, la
legge 133 del 6 agosto (anniversario di Hiroshima!) è stata
devastante. Otto miliardi di euro in meno alla Scuola Statale
(mentre si regalavano cifre ragguardevoli alle scuole private) si
sono poi tradotti in una “riforma” (comunemente ricordata con il
nome dell’allora Ministra Gelmini) che a molti è sembrata in realtà
il mascheramento di una mera operazione di taglio lineare dei
finanziamenti, e quindi delle ore d’insegnamento, dei laboratori,
delle cattedre, dei posti di lavoro.
Negli altri Paesi civili, quando si vuole che un’istituzione
funzioni meglio, se ne progetta prima una riforma complessiva,
improntata a criteri relativi al funzionamento dell’istituzione
stessa (e non meramente economicistici); quindi se ne discute in
Parlamento, informandone l’opinione pubblica e ascoltando le
reazioni di quest’ultima; infine si finanzia adeguatamente
l’operazione. Dopo qualche anno, se ne valutano gli effetti, con
studi statistici a campione. Infine, se necessario, si corregge il
tiro, eliminando eventuali sprechi e investendo ove necessario.
In Italia si fa il contrario. Dopo decenni di offese ai Docenti e al
loro lavoro, mentre i problemi reali della Scuola venivano lasciati
incancrenire dai vari Governi (senza mai un intervento complessivo
né una visione pedagogica d’insieme), in un giorno d’agosto, con gli
Italiani sulle spiagge, è stata resa nota una legge di natura
finanziaria che tagliava alla Scuola gran parte delle risorse ad
essa necessarie per sopravvivere.
Cinque anni dopo ci troviamo a fare i conti con le ferite e le
patologie accumulate sulle patologie e sulle ferite già esistenti
prima della “riforma”.
Il nostro istituto (il Liceo “Terenzio “Mamiani”) è un Liceo
Classico; dunque prenderemo in esame gli effetti sul Liceo Classico.
Dove, paradossalmente, le cattedre più colpite sono state proprio
quelle della classe di concorso A052 (“Italiano, latino, greco,
storia, geografia nel Liceo Classico”). L’insegnamento dell’italiano
è stato ridotto di un’ora a settimana: un’ora su cinque significa il
venti per cento in meno. Un taglio drastico, che certo non può
rendere i Docenti di italiano più capaci di terminare i programmi.
Per facilitarli, il MIUR ha pensato bene di riformulare i programmi
stessi: aumentandone i contenuti! Di fatto ora i Docenti di quinta
ginnasiale dovrebbero, oltre a completare il programma consueto,
insegnare ai quindicenni anche la poesia italiana delle origini,
precedentemente insegnata in prima liceale.
Eppure tutti sanno che al Ginnasio giungono ormai ragazzi con
gravissime lacune a livello grammaticale, ortografico, sintattico,
per colmare le quali i Docenti hanno già il loro bel daffare. Che
senso ha, dunque, aver diminuito il tempo da dedicare all’italiano,
aumentando nel contempo la quantità di nozioni e anticipando di un
anno i contenuti storico-letterari, che richiedono uno studio ben
più approfondito e capacità cognitive ben più sviluppate?
Altra nota dolente: la geografia; già relegata al ruolo di
cenerentola prima della cosiddetta “riforma”, e che dalla “riforma”
è stata dimezzata. In realtà delle due ore settimanali, di cui prima
godeva questo fondamentale insegnamento, non ne rimane che una, per
di più accorpata alla storia. Di conseguenza i Docenti si
scervellano per valutare gli studenti con un voto unico che tenga
conto di entrambe le discipline, così diverse (benché complementari)
per metodi, strumenti, campi d’indagine.
Quale la ratio di un’operazione simile? Modernizzare la Scuola?
Facilitare il lavoro dei Docenti? Mettere gli studenti a proprio
agio? Se vogliamo prenderci in giro, narriamoci pure queste favole.
Altra è la realtà, ben altro lo scopo. Tagliare un’ora all’italiano
e una alla geografia serve a ridurre di due ore la cattedra dei
Docenti A052 (da 18 a 16 ore settimanali) e per poterne licenziare
uno ogni nove. Altro che riforma!
Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Le cattedre di lettere sono
frantumate, la continuità didattica non esiste più. Difatti l’aver
tolto due ore alle diciotto tradizionalmente attribuite alla
cattedra di lettere (obbligando nel contempo tutti i Docenti a
svolgere in aula diciotto ore d’insegnamento) ha comportato
l’impossibilità di realizzare cattedre unitarie. Ed ecco che i
nostri quattordicenni del Ginnasio si ritrovano spesso quattro
insegnanti di lettere: uno per l’italiano, uno per il latino, uno
per il greco, uno per la storia/geografia (che i più volenterosi
chiamano “geostoria”, facendo rivoltare nella tomba Nicola
Zingarelli).
Nessuna cattedra è ormai garantita. Nessun Docente sa quale classe
avrà l’anno successivo, nessuno studente conosce il nome dei propri
prossimi insegnanti. Questo perché nell’organizzazione della Scuola
non esiste più altro criterio guida se non il risparmio. Quasi che
l’ignoranza indotta dallo sfascio della Scuola Statale fosse alla
lunga meno costosa della Scuola stessa.
Ma non è finita qui. Infatti gli Insegnanti della classe di concorso
A052 (“Materie letterarie, latino e greco nel Liceo Classico”) si
vedono sempre più relegati ad insegnare solo greco; oppure ridotti a
insegnare non più il greco, ma le altre materie letterarie, e fuori
dal Liceo Classico. Infatti la Nota Ministeriale n. 272 del 14 marzo
2011, consente di insegnare le altre materie letterarie nel Ginnasio
anche ai Docenti di Lettere non abilitati all’insegnamento del
greco; ossia a quelli della classe A051 (“Materie letterarie e
latino nei Licei e nell’Istituto Magistrale”), le cui cattedre sono
state crudelmente decimate dai tagli (definiti “riforma”) della
Scuola pubblica. Per edulcorare le difficoltà dei troppi
soprannumerari della A051 (incrementati dalla feroce riduzione di
ore in discipline importantissime come italiano e latino), il MIUR
ha architettato la consueta operazione aritmetica, semplicemente
spalmando sul Liceo Classico gli Insegnanti non abilitati per il
Ginnasio, in concorrenza con quelli della A052, i quali sono forniti
invece del titolo di studio e dell’abilitazione previsti. Ecco la
“meritocrazia” dei Governi italioti!
Last but not least (per parlare come i commentatori di successo): il
continuo attacco ideologico contro le lingue classiche (apostrofate
spesso come “morte”, o “ostiche”, quando non “inutili”) ha
comportato la loro progressiva svalutazione. Così sempre meno
studenti si iscrivono al liceo classico, quelli che si iscrivono
sono meno motivati (anche per i problemi di cui sopra), e sempre
meno hanno gli strumenti per padroneggiare l’italiano.
In una situazione così compromessa si pretende di valutare studenti,
Docenti e scuole. Facendolo, per di più, tramite test uguali da
Bolzano a Pantelleria, dal miglior liceo di Milano al più modesto
istituto professionale di Canicattì. Sfugge, francamente, il
criterio di un’operazione di tal fatta. Sfugge anche il motivo per
cui i test dell’Invalsi riguardino solo le competenze relative
all’italiano, ma non quelle del latino, del greco, della storia e
della geografia.
Della validità dei test parleranno altri relatori nel corso di
questo convegno, ben più esperti di me in materia e con opinioni
diverse sull’argomento. Io mi limiterò a proporre ancora spunti di
riflessione sulla condizione dei Licei Classici, fino a cinque anni
fa fiore all’occhiello del sistema scolastico italiano.
Il nostro Liceo “Mamiani” ancora resiste, sia perché gode di una
lunga tradizione (essendo uno dei Licei storici della Capitale), sia
per opera di un Collegio dei Docenti cosciente e combattivo, sia per
aver sempre avuto Dirigenti intelligenti e capaci. Purtroppo, però,
le notizie che giungono ai terminali sindacali di base dai Licei di
provincia (spesso anche molto prestigiosi) sono scoraggianti.
Complici, molto spesso, purtroppo, molti degli stessi Docenti, non
coscienti del proprio ruolo, della propria funzione, dei propri
diritti. Troppi Insegnanti si lasciano calpestare da alcuni
“presidi-manager” per timore e perché non sindacalizzati. Inoltre i
sindacati “maggiormente rappresentativi” da troppi decenni
rappresentano soltanto sé stessi e la controparte governativa. Gli
unici sindacati che difendano chi lo merita sono l’Unicobas e pochi
altri sindacati di base, ai quali, per accordi sindacali concertati
dai sindacati maggiori, sono vietate persino le assemblee in orario
di servizio.
La libertà di insegnamento, un tempo cardine del sistema scolastico,
sta per esser cancellata da una pseudodidattica (della quale
traboccano i libri di testo) finalizzata al superamento delle prove
Invalsi.
I Docenti si sentono intimiditi e condizionati (quando non
ricattati) dall’opinione dei genitori e dei Dirigenti, sempre più
aggressivi nei loro confronti negli organi collegiali. Ciò non
avviene solo nel profondo Sud, tra infrastrutture fatiscenti,
difficoltà logistiche inimmaginabili, camorristi e mafiosi nei
comitati di genitori e nei consigli di classe; avviene anche nel
Nord più opulento, dove la cultura non viene considerata nemmeno più
uno status symbol, e dove conta semmai il semplice conseguimento del
“pezzo di carta”.
Per i Docenti non c’è più neppure la libertà di valutare le
verifiche scritte, perché in molti casi le correzioni avvengono in
comune, con griglie di valutazione discutibili (quando non assurde),
che determinano, tra l’altro, polemiche, perdite di tempo e
situazioni caotiche per stabilire i calendari delle riunioni. Agli
Insegnanti viene proibito di usare voti intermedi, che
permetterebbero di sfumare i giudizi e di evitare grossolane
semplificazioni.
Proibito ai Professori assegnare voti più bassi del tre, persino
quando l’allievo consegna una verifica in bianco. In alcuni noti
Licei milanesi è vietato dar voti inferiori al quattro, e si pratica
lo “scambismo” delle verifiche: appunto per far apparire le
correzioni più “oggettive”, i Docenti si scambiano vicendevolmente
gli elaborati per correggerli e valutarli. Come se rinunciare a
valutare personalmente i risultati del proprio lavoro servisse a
renderlo più affidabile. Una pratica che è semmai il frutto più
maturo dell’insicurezza indotta nei Docenti italiani da un
trentennio di denigrazione e calunnie nei loro confronti.
In quasi tutti i Licei d’Italia l’anno scolastico non è più scandito
in due quadrimestri, ma in un trimestre e in un periodo di cinque
mesi (definito “pentamestre”, con un ennesimo, orrido neologismo
scolastichese). In alcuni casi la finalità è didattica; in altri,
serve solo a far contenta la cosiddetta “utenza”, la quale, specie
se benestante, può così andar tranquilla sulla neve durante le
vacanze natalizie, senza preoccuparsi di far studiare i pargoli
prima del rientro a scuola. Invero molti studenti, dopo lo scrutinio
del 20 dicembre, non aprono libro fino alla fine di gennaio.
Decisioni del genere passano però nei Collegi dei Docenti
all’unanimità o quasi, perché l’impressione comune è che sia già
tutto deciso, e che sia inutile (quando non rischioso) opporsi.
In moltissimi Licei è stata introdotta la settimana corta,
semplicemente perché voluta da Dirigenti e comitati di genitori (dai
quali provengono quei denari che lo Stato preferisce regalare ai
diplomifici privati). In questo modo gli studenti tornano a casa
molto tardi nel pomeriggio e si ritrovano sei o sette materie da
studiare per il giorno successivo. Ma tanto, si sa, lo studio è
ormai un optional.
I Docenti non sono più liberi di scegliere i libri di testo, spesso
uguali per tutte le classi e decisi nelle riunioni di
“dipartimento”, secondo criteri spesso poco trasparenti. Si studia
poco persino Dante: in molte classi non ne viene adottata alcuna
edizione, tanto che alcune classi liceali leggono al massimo quattro
canti della Divina Commedia in un anno. Per non superare il tetto di
spesa stabilito dal MIUR, non si adottano più antologie latine né
greche, né libri di versioni. I genitori però di questo non sembrano
preoccupati, rivolgendo semmai le proprie attenzioni (soprattutto
nei Licei del Nord) verso le vacanze-studio dei figli in Inghilterra
(o alle Isole Hawaii!), o verso i loro cellulari ultimo grido, o
verso costose psicoterapie per i propri pupilli.
Pur di non perdere iscritti, si permette comunque ai medesimi
genitori di prendere la parola persino nei Collegi dei Docenti:
tanta e tale è la paura dell’accorpamento con altre scuole, il quale
scatta inesorabile quando il numero degli alunni scende sotto il
fatidico numero di seicento.
I Docenti che non si piegano e non si uniformano all’ideologia della
scuola-azienda, se non è possibile farli fuori in altro modo (perché
troppo esperti o con troppo punteggio in graduatoria), si vedono
assegnare le cattedre più spezzettate; oppure viene loro impedito di
insegnare la disciplina che più amano, anche a costo di danneggiare
gli studenti.
Ebbene, dopo che la Scuola Statale italiana ha dovuto subire tutto
questo, la si vuole valutare. E valutarla non a partire dai
Ministri, dai sottosegretari, dalla burocrazia, dagli edifici
fatiscenti, dai finanziamenti negati e da tutto quello che la
strozza; ma dagli studenti e dai Docenti.
“A pensar male degli altri si fa peccato, ma spesso ci si indovina”
diceva Giulio Andreotti. Forse fa peccato anche chi pensa che lo
sfascio della Scuola sia stato progettato e portato avanti con
lucida e paziente determinazione da quella medesima classe politica
e dirigenziale che ha già sfasciato e privatizzato mezza Italia, e
che ora vuol privatizzare anche la Scuola istituita dalla
Costituzione. Fa peccato; ma probabilmente indovina.
|