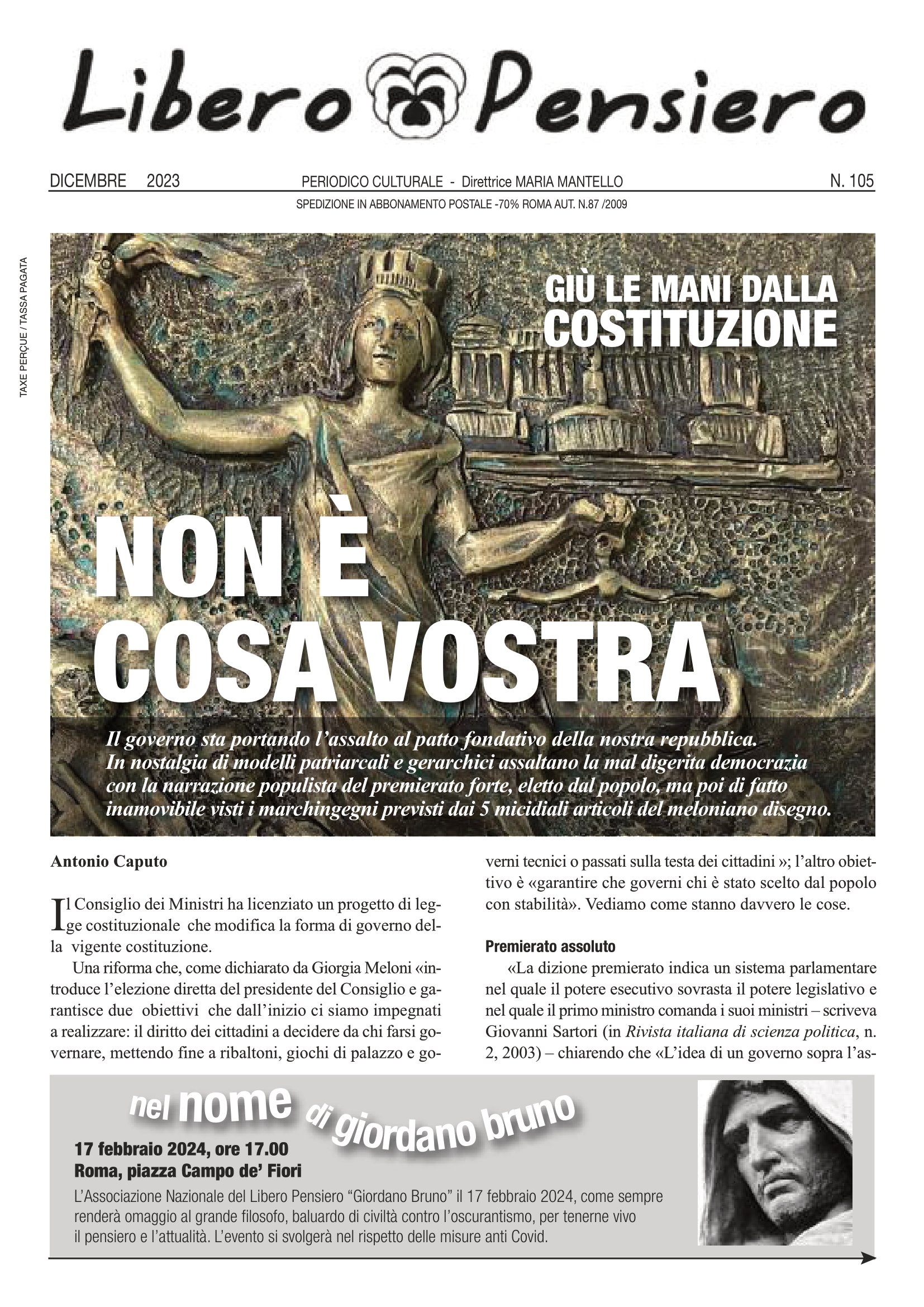|
|
|
Associazione Nazionale del Libero Pensiero "Giordano Bruno" |
| |||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
Arturo Napoletano: Giordano Bruno - sulle ali della libertà di pensiero
Non siamo i soli a ricordare Giordano Bruno. Non lo possono dimenticare quanti difendono la libertà del pensiero e non lo hanno certamente dimenticato quanti, nel buio silenzioso della vergogna, ancora si ostinano, dopo quattro secoli, a non condannare l’infamia dei suoi persecutori: Giordano Bruno appartiene alla memoria collettiva del genere umano. Quella libertà che egli rivendicò per sé fu, e sempre sarà, difficile e rischiosa, non solo perché ogni stagione della storia ha i suoi inquisitori, ma anche perché il pensiero non ci prospetta mondi rassicuranti e celesti salvatori. Il pensiero esige coraggio e fatica. Se consideriamo con quante favole l’uomo ha cercato di nascondere l’orrore dell’ignoto, si può anche dare ragione al Poeta quando afferma che noi siamo fatti della stessa materia con cui sono fatti i sogni. Eppure l’uomo non è stato costruito per vivere una notte senza aurora e finisce col pagare in moneta sonante ogni rinuncia ad entrare nell’orizzonte della realtà. Paga restando confinato nelle propria miseria materiale ed esistenziale e più ancora, con la inevitabile trasformazione dei sogni in incubi. Solo il libero pensiero, con il suo sobrio coraggio, può allontanare i mostri che vengono evocati dal tenebroso mondo dei sogni. In questa luogo, uomini che vivevano di incubi hanno cercato di spegnere la voce di un intelletto che, aprendo gli occhi della mente sugli orizzonti dell’universo copernicano, ha mostrato come anche il pensiero abbia i suoi paradisi, paradisi dei quali lui è stato uno dei pochi privilegiati esploratori. Da queste lontane regioni non si torna che profondamente trasformati e ce lo testimonia lo stesso Giordano Bruno: Alla mente che ha ispirato il mio cuore con arditezza d’immaginazione piacque dotarmi le spalle di ali e condurre il mio cuore verso una meta stabilita da un ordine eccelso, in nome del quale è possibile disprezzare e la fortuna e la morte. Si aprono arcane porte e si spezzano le catene che solo pochi elusero e da cui solo pochi si sciolsero […]. Io sorgo impavido a solcare coll’ali l’immensità dello spazio. Queste parole mostrano un aspetto del sapere che i nemici del libero pensiero ed i mercanti che lucrano sulla scienza tengono a lasciare in ombra: la sua capacità di esaltare l’uomo. Questa capacità di travalicare la nostra limitatezza e di trasporci in orizzonti più vasti è stata sempre concepita dai più grandi uomini di scienza come l’asse portante della loro ispirazione etica. Il matematico Henri Poincaré, ponendosi la questione sul perché sia giusto studiare l’astronomia e perché siano ben spesi i quattrini che vengono profusi per coltivare una scienza tanto lontana dai nostri immediati interessi, così scrive: L’astronomia è utile perché ci eleva al di sopra di noi stessi; ci è utile perché è grande e perché è bella: ecco ciò che bisogna dire. Nessuna superiorità morale va riconosciuta, pertanto, a quanti ci avvelenano con i loro incubi. Bisogna, anzi, strappare dalle loro mani omicide la bandiera degli ideali e della moralità. Arroccandosi nel castello delle fedi, si contrastano le tendenze naturali della nostra specie. La volontà di conoscere è il motore dell’evoluzione culturale dell’umanità; un motore potente che ha spinto l’homo sapiens sapiens dalle savane allo spazio circum-terrestre. Le verità del sapere non si dimostrano con guerre vittoriose e sterminatrici, non si difendono con torture e roghi, sono verità che tanto più rilucono quanto più gli uomini collaborano fra loro, quanto più osano aprire gli occhi sui panorami vastissimi del mondo reale e quanto più sanno gustare le bellezze delle sue geometriche armonie. Noi, ricordando Bruno, non torniamo indietro nel tempo; ci poniamo, invece, a fronte del nostro futuro; un futuro che ora ci appare come un libro chiuso, dal contenuto inquietante. Noi uomini della modernità non avremo alcun futuro se dimenticheremo gli ideali che hanno dato a Giordano Bruno le ali per solcare col pensiero l’immensità degli spazî e sovrastare con coraggio la morte. Per noi vale ancora la domanda che un filosofo rivolse a sé stesso: Come potrei tollerare di essere uomo, se l’uomo non fosse anche poeta e profeta e liberatore dalla brutalità del caso? Chi avvilisce il libero pensiero consegna l’uomo alla brutalità del caso, rende intollerabile e vacua la condizione umana, suscita mostri che ci divorano. Questi mostri hanno ucciso Bruno e vivono ancora fra noi; attingono forza dalle tenebre dell’ignoranza; ma altri mostri, ancora, sono acquattati dietro la linea del nostro orizzonte, pronti a sbarrare il cammino dell’umanità. Viviamo una stagione di rischi estremi, eppure gravida delle più esaltanti prospettive. L’uomo della modernità ha bisogno di ritrovare le ragioni dell’umanesimo bruniano, ovvero di un umanesimo saldamente ancorato alle idealità della scienza. Oggi questi ideali non sono minacciati solo dalle grida inconsulte e dalla sanguinaria violenza degli integralismi religiosi. La battaglia gigantesca nella quale è caduto Giordano Bruno non è conclusa. È, anzi, in una fase acuta, in un momento difficile che alimenta in molti frustrazione ed anche disperazione. Tutta la nostra civiltà dell’Occidente sembra volgere al tramonto. Un cupo senso di ansia, la paura del futuro si stanno impadronendo dell’uomo moderno. Più avanza la capacità manipolativa della tecnica e più l’uomo si scopre nudo e solo in un mondo che si sta trasformando in una macchina mostruosa. Questa angosciosa condizione ci scopre un’altra verità: l’uomo moderno, privo della linfa vitale di quell’umanesimo di cui Bruno fu testimone, non è portatore di alcuna speranza. Ridotti sempre più nella condizione di massa, gli uomini moderni, piegati sotto la sferza della volgarità consumistica, se ne stanno aggrappati al vuoto del presente, incapaci di costruire il futuro. La grandezza dell’universo schiuso dalla scienza, la sua profonda complessità, esigono altrettanta grandezza nell’uomo; esigono da noi una palingenesi e Bruno ce ne ha indicato la strada. Al gusto dell’arraffare, alla violenza inconsulta contro la natura, agli integralismi degli ignoranti volontarî, bisogna sostituire la serietà fascinosa del sapere. Ad un’etica che ancora pone l’uomo e le sue illusioni al centro del mondo, bisogna sostituire un’etica che ci trasponga nell’universo di Copernico e Darwin. Noi, uomini dell’era copernicana, non siamo più nell’Eden che aveva costruito la nostra immaginazione. Oltre il mondo umano, c’è un vasto ed inconquistabile universo. E noi gli apparteniamo. Il vero problema per l’umanità del futuro sarà come abitarlo. In questo compito l’insegnamento bruniano si rivela cruciale. Esso indica una via da percorrere. L’uomo della modernità sembra essersi fermato sulla sponda di un gran mare. Frustrato e spaurito, non osa salire sulla nave e sciogliere gli ormeggi. Si aprono arcane porte e si spezzano le catene, ha scritto Giordano Bruno; ma l’uomo moderno se ne sta ancora dietro ben serrate porte di bronzo; non riesce a far sprizzare dal pensiero tutta la sua carica salvifica. La rivoluzione copernicana, quel rivolgimento delle conoscenze che ha dato le ali a Giordano Bruno per solcare l’immensità dello spazio, invoca una più ampia rivoluzione nel mondo umano. Giordano Bruno ha schiuso questa prospettiva e se ne è fatto profeta. Il suo insegnamento porta con sé una più grande speranza. Le fiaccole che ne bruciarono il corpo si sono spente da lungo tempo, non si è spento il fuoco suscitato dal suo messaggio perché, come è stato detto, quando un grande pensatore viene sulla terra tutto è in pericolo. È come se in una città fosse scoppiato un incendio e nessuno più sapesse che cosa è al sicuro e dove l’incendio finisce. L’amore per la verità è qualcosa di terribile e di possente
| |||||||||||